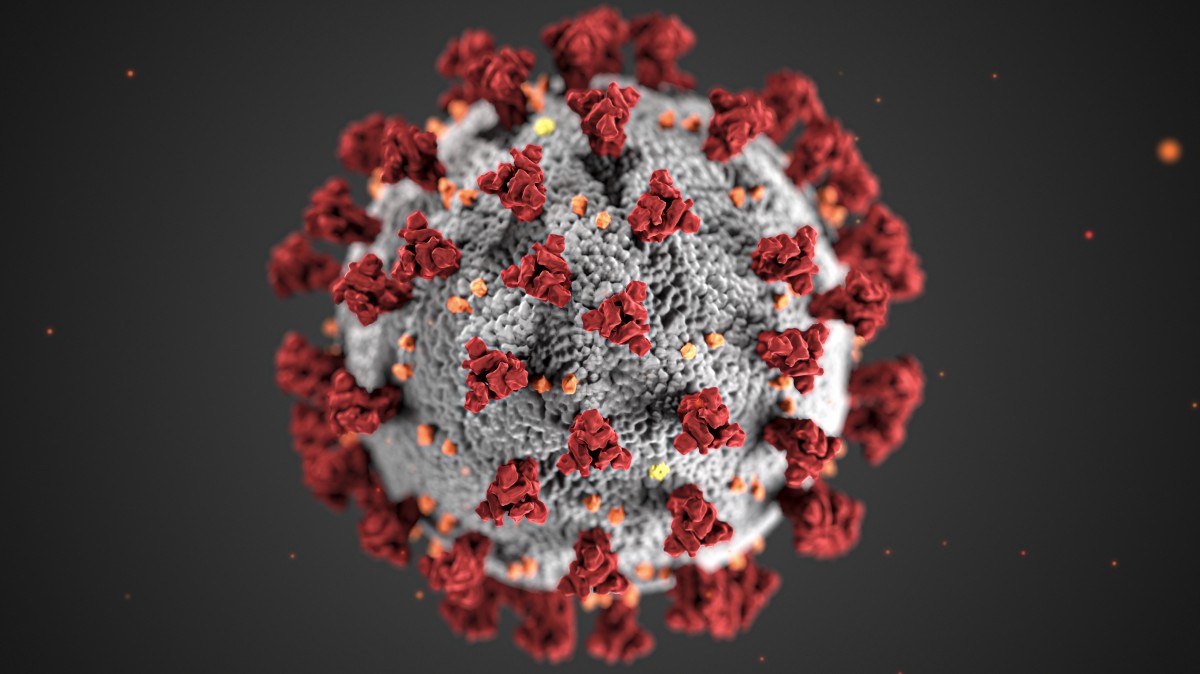La mala sanità si annida anche in comportamenti scontati, conosciuti, è legittimata da procedure burocratiche, incarognita dalle complicità tra poteri forti. Questa è una storia di appelli rimasti inascoltati, di una Regione in cui il 7 luglio scorso si considerava «superata la fase di emergenza» e in cui pochi mesi dopo sono saltati monitoraggio dei malati e tracciamento dei contagi
«Questa storia è iniziata per me il 23 febbraio, quando ho acquistato online un kit di sopravvivenza: camici, mascherine, calzari, cuffie, occhiali a perdere». A parlare è Sergio Luzzi Galeazzi, medico in servizio a Terni. La definizione «kit di sopravvivenza» potrebbe apparire sulle prime esagerata. Ma se si fa riferimento al momento in cui è stata compiuta l’azione e al fatto che a parlare è un medico di medicina generale (MMG), la sorpresa si ridimensiona. Siamo al 23 febbraio; erano passati due giorni dalla scoperta del primo paziente positivo al covid, che pareva un morbo che ci avrebbe toccato solo di striscio a noi, così lontani dalla Cina. I dispositivi di protezione, per una lunga prima parte dell’epidemia sono stati sottovalutati, ed erano pressoché introvabili; e poi di quel virus non si stava capendo ancora nulla. Sergio Luzzi, da medico, ha invece intuito che occorreva prevenire, proteggersi.
La prima linea non è e non è stata solo quella dei medici e degli infermieri che l’hanno vissuta e la stanno vivendo negli ospedali. La prima linea è stata anche di quei tanti medici di medicina generale che da mesi ricevono decine di telefonate, allarmi, confidenze, richieste, fanno o hanno fatto visite domiciliari senza però essere dotati di tutti gli strumenti per agire col massimo dell’efficacia e della sicurezza, molti morti sul campo. La storia di Luzzi Galeazzi («lavoro quattordici ore al giorno, e con me tutto il personale dello studio che non smetterò mai di ringraziare») ci dice questo. Ed è una storia da ascoltare, perché ribalta la prospettiva, che qui non è più quella dei numeri snocciolati di sera in sera, degli opinionisti da salotto televisivo o dei proclami di leader politici ignari di quello che succede davvero. Qui la prospettiva è quella di chi sa «con un mese di anticipo cosa ci sarà scritto nei dati che ci daranno nei tg». La misura di quello che sarà sono le telefonate degli assistiti, le richieste di intervento, le febbri sospette, le tossi persistenti di pazienti che conosci da anni e che rappresentano per questo un termometro formidabile di cosa succede qui, sulla terra, prima di arrivare ai piani alti. E la storia è interessante perché dice di quanti errori e sottovalutazioni è costellato il percorso iniziato a marzo. Sbagli e storture che un medico di medicina generale come Luzzi ha colto in tempo reale. E segnalati invano.
Le prime dieci mascherine
le abbiamo ricevute il 20 marzo,
dopo quasi un mese di lockdown
poi non abbiamo visto più niente
Sono due le questioni principali, e sono racchiuse in diverse email che Luzzi Galeazzi ha inviato in lungo e largo – ai vertici della sanità regionale, al suo sindacato di categoria, alla Protezione civile e a virologi di fama onnipresenti in tv – per segnalare come con pochi accorgimenti si sarebbe potuto lavorare e curare meglio. Ma intanto: chi è Sergio Luzzi Galeazzi? «Ho 65 anni, di cui 41 di servizio, e lavoro a Terni in uno studio medico associato in forma di cooperativa, la Medipiave, di cui sono presidente. Siamo otto medici, più altri quattro che ruotano per la continuità assistenziale, quattro impiegate amministrative e due infermiere. In tutto abbiamo 11 mila assistiti, che rappresentano il dieci per cento dell’intera popolazione cittadina». Ecco a cosa ci riferiamo quando parliamo di “terra”, ed ecco perché Luzzi Galeazzi e quelli come lui possono essere considerati in prima linea: perché quelle migliaia di cittadini impauriti in questi mesi di pandemia hanno avuto i medici di medicina generale come primo approdo, e i medici di medicina generale avrebbero rappresentato, se li si fosse ascoltati, un punto di osservazione e azione privilegiato. Medici che hanno dovuto provvedere da sé a proteggersi e che, per usare un eufemismo, non sono stati aiutati a svolgere al meglio il loro lavoro. Anzi: «Solo il 20 marzo, a un mese dallo scoppio della pandemia in Italia e in pieno lockdown, ci hanno inviato le prime dieci mascherine chirurgiche, poi più niente», sottolinea Luzzi Galeazzi.
Le ricette impazzite
«Il 21 marzo ho blindato lo studio: niente sportello, niente accessi spontanei, solo visite programmate a distanza di un’ora l’una dall’altra per evitare incroci di persone nei locali. Il problema è che eravamo subissati di richieste. Da un lato c’era la paura del virus, dall’altro le patologie ordinarie e la richiesta di prescrizione di ricette che in condizioni di necessità di distanziamento è diventata un problema: perché la ricetta va consegnata alla persona interessata, che poi con il cartaceo va in farmacia e prende quello che le occorre. Una catena che si potrebbe accorciare agevolmente, e questo garantirebbe risparmi di tempo e risorse per tutti, e per di più la messa in sicurezza degli ambulatori, fattore non secondario in tempi di pandemia». Per questo Luzzi Galeazzi è tornato in sella a quello che da anni è un suo cavallo di battaglia: la dematerializzazione pura delle ricette, tanto più cruciale oggi. Ha scritto ai vertici della Federazione dei medici di famiglia, la Fimmg, al direttore generale della sanità umbra Claudio Dario, e infine anche al commissario per il coronavirus in Umbria, Antonio Onnis. Senza risultati. «Io – dice – non capisco questa ritrosia nell’innovazione se non con la necessità di qualcuno di mantenere rendite di posizione. In Trentino la ricetta dematerializzata è una realtà dal 2016. Funziona così: il medico prescrive i farmaci e invia la ricetta direttamente al fascicolo sanitario elettronico, le farmacie di tutto il territorio possono accedere direttamente al fascicolo e l’assistito può prelevare i farmaci prescritti semplicemente presentando la tessera sanitaria. In questo modo si sarebbero evitate file e lungaggini, e si sarebbe risparmiato tempo per noi prezioso per contribuire in maniera fattiva a un’opera di prevenzione per il coronavirus dalla quale siamo stati di fatto esclusi. Attualmente siamo costretti ad inviare al paziente il codice NRE (Numero di ricetta elettronica, ndr) o la ricetta via mail. L’assistito può recarsi in farmacia e ritirare i farmaci anche esibendo il solo codice NRE dal suo smartphone. Già è un passo in avanti, certo, ma per le persone anziane e fragili che non hanno uno smartphone? La soluzione proveniva dalla Toscana, che ha messo a disposizione gratuitamente un’infrastruttura telematica che avrebbe potuto essere utilizzata gratuitamente per l’invio automatico degli NRE via sms, ma l’Umbria ha rifiutato l’offerta vantaggiosissima perché i costi degli sms, stimati in circa 150 mila euro l’anno per tutti i 900 mila cittadini della regione, cioè 16 centesimi a cittadino, sono stati considerati troppo onerosi, e ha puntato su una rapida dematerializzazione completa che a distanza di sei mesi non si è vista», dice sconsolato Luzzi. E perché? «Perché non si riesce a mettere allo stesso tavolo Regione, Sogei (la società del ministero del Tesoro che dovrebbe curare l’infrastruttura telematica dell’operazione) e Farmaservice, che impiega diverse persone proprio nell’ammazzettamento delle ricette cartacee». Resistenze burocratiche e di difesa di interessi.
La sottovalutazione: «L’emergenza è superata»
A questo punto però conviene fare un passo indietro, che oltre a far constatare rigidità burocratiche inopportune, consente anche di toccare con mano quanto l’emergenza sia stata sottovalutata. Il 19 marzo, in pieno lockdown, la Protezione civile emette l’ordinanza 651 con la quale si dematerializzano parzialmente le ricette ma si inibisce ai medici di inviare il documento direttamente alle farmacie: la ricetta elettronica o il NRE possono essere inviati solo ai diretti interessati tramite email o sms. Con buona pace di tutti quegli assistiti anziani, e ce ne sono tanti, che non dispongono o non hanno dimestichezza con computer e smartphone. Questioni di privacy, si sostiene. E di possibile comparaggio (il reato nel quale incorrono medico e farmacista che si mettano d’accordo per lucrare sui farmaci venduti). In Umbria si fa un ulteriore passettino in avanti. Il 16 aprile il direttore del Dipartimento assistenza farmaceutica della Usl 2, Fausto Bartolini, comunica ai medici e ai pediatri di libera scelta che in ottemperanza di un’ordinanza della Regione, «qualora il paziente non abbia confidenza con strumenti informatizzati o telefonia mobile per ricevere il numero di ricetta elettronica, il medico, su indicazione dello stesso paziente, deve trasmettere l’NRE via mail alla farmacia più vicina alla sua residenza». Non siamo alla ricetta elettronica, però questo consente almeno di evitare l’intasamento degli ambulatori e di far rifiatare, seppur parzialmente, i medici. Ma evidentemente anche questo piccolo progresso è considerato eccessivo. Perché il 7 luglio Bartolini emette un’altra comunicazione. E qui occorre fare attenzione alle parole, che evidenziamo in corsivo: «Valutando ad oggi superata la fase di emergenza, si ritiene indispensabile l’adesione alle indicazioni contenute nell’ordinanza della Protezione civile numero 651 del 19 marzo 2020». Quel documento ci dice che non solo si sono di fatto rimaterializzate le ricette, ma che il 7 luglio 2020 i vertici sanitari della Regione consideravano «superata la fase di emergenza».
Chi decide sui tamponi?
Questo squaderna molti dei motivi per cui oggi stiamo messi così male di fronte al covid. E ci porta dritti, dopo quello della negata dematerializzazione delle ricette e dei negati dispositivi di protezione per i MMG, all’altro problema sollevato da Luzzi Galeazzi, che lui riassume così: «All’inizio della pandemia occorreva andarci piano coi tamponi perché, si diceva, non c’erano reagenti a sufficienza, anche se Crisanti in Veneto ha dimostrato che i reagenti potevano essere prodotti in house senza problemi e senza grande dispendio di soldi. Oggi non c’è personale a sufficienza per processarli. Ma i tamponi sono l’unica vera possibilità di fare prevenzione, e se li si utilizza così si capisce come siamo arrivati a questo stato». Del resto, se il 7 luglio in Regione si valutava «superata la fase di emergenza», perché perdere tempo a individuare una efficace strategia di gestione dei tamponi e del tracciamento? E infatti, quale è stata la traduzione sul campo delle parole-denuncia di Luzzi Galeazzi? «All’inizio della pandemia – spiega il medico – il protocollo della Regione Umbria imponeva di fare i tamponi solo a persone con sintomi che avessero avuto un contatto certo con un positivo al covid. Io l’ho scritto fin da marzo che se non facevamo i tamponi a chi aveva la febbre rischiavamo di mandare in giro chissà quante persone infettate che hanno infettato a loro volta. A noi medici di medicina generale è stato precluso fino a metà ottobre di decidere direttamente a chi fare i tamponi. Se ci imbattevamo in un caso sospetto, dovevamo chiamare il numero verde che ci forniva il numero del reperibile, il quale riempiva una scheda e segnalava il caso al medico del dipartimento di prevenzione, che a sua volta chiamava il centro di salute che organizzava il tampone. Capisci che in un’emergenza in cui per fare prevenzione è fondamentale la tempestività della diagnosi, procedere in questo modo è un controsenso. E infatti il risultato è che dal caso sospetto alla diagnosi di positività passavano 7-10 giorni. Come si fa a fare il tracciamento dei contatti dopo dieci giorni? Il fatto è – prosegue Luzzi – che l’assioma per cui tutti i casi sospetti debbano essere considerati covid fino a prova contraria, e non viceversa, è a tutt’oggi poco chiaro sia ai politici che ai medici e ai pediatri. Soprattutto questi ultimi tendono a sottovalutare perché nei bambini il virus non produce conseguenze gravi. Vero, però un bambino positivo ancorché asintomatico può infettare famiglie intere».
L’allarme inascoltato di agosto
Alla decisione di coinvolgere direttamente i MMG nella decisione delle persone da sottoporre a tampone si è arrivati a metà ottobre. In quel momento i casi crescevano già da settimane in maniera esponenziale e si viaggiava al ritmo di duecento nuovi positivi al giorno. E dire che, nonostante il 7 luglio si considerasse chiusa l’emergenza, già dal 4 agosto si cominciavano ad avere segnali “dalla terra”. Quel giorno Antonio Onnis, il commissario umbro per l’emergenza covid, diramava disposizioni alle Usl e alle aziende ospedaliere «in merito alle numerose richieste di interventi domiciliari inoltrate in questo periodo per casi sospetti covid» (corsivo nostro). Ciò nonostante, prima di arrivare a far decidere in autonomia e tempestivamente ai medici “sulla terra” chi tamponare, trascorreranno ancora più di due mesi: il manuale per la richiesta “diretta” dei tamponi attraverso il sistema informatico della sanità regionale verrà diramato ai MMG il 24 ottobre, giorno in cui si registravano 525 nuovi positivi in Umbria. Una situazione in cui stava diventando impossibile effettuare un tracciamento, a meno di non decidere di fare lo screening di massa come in provincia di Bolzano (ne abbiamo parlato in questo articolo), cosa che non è stata fatta; anzi, lo stesso Onnis il 23 ottobre getta di fatto la spugna e comunica alla stampa il «cambio di strategia»: si faranno tamponi solo ai sintomatici, con la conseguenza che gli asintomatici continueranno a essere ignari e infettare. Il «cambio di strategia» viene giustificato con la gravità, a fine ottobre, dell’emergenza che a luglio veniva data per chiusa e ad agosto si era invece già riaffacciata, e si sapeva, come dimostrano le carte.
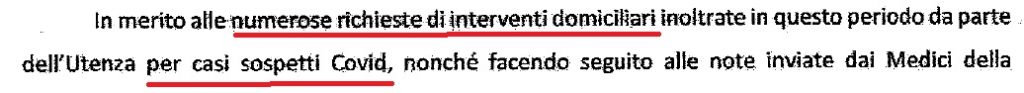 La Beffa finale con i tamponi antigenici (rapidi)
La Beffa finale con i tamponi antigenici (rapidi)
Di fronte al crescente dibattito su come si potesse rafforzare il territorio per evitare impropri ricoveri ospedalieri da covid, il Governo e le regioni, invece di investire sul tracciamento manuale e sulla tempestività della diagnosi, hanno pensato bene di fare un accordo con la Fimmg, che è il sindacato più importante e rappresentativo dei MMG, per eseguire i tamponi rapidi con l’obiettivo di farli direttamente all’interno degli studi o in altro luogo da definire, ovviamente, si assicura, con tutte le protezioni individuali del caso. «Mi domando: come mai in otto mesi le stesse protezioni richieste a gran voce non sono mai arrivate e ora invece sarebbero a chiacchiere disponibili? – chiede amaramente il medico -. Nel frattempo sono morti oltre 200 medici per questa pandemia e di questi oltre 150 MMG senza protezioni». Luzzi Galeazzi ritiene inefficace anche l’azione proposta: «Si vorrebbe fare il tampone rapido ai pazienti con sospetto di malattia o a quelli in uscita dalla quarantena. Però, vedi, il tampone antigenico rapido è utilissimo per fare lo screening a una popolazione sana di grandi numeri e in tempi rapidissimi con lo scopo di individuare gli asintomatici. Per esempio: una scuola, un paese, una istituzione (tutti i dipendenti della Usl). Non è invece utile per fare diagnosi, che sia la prima di positività, o quella di fine malattia. Questo perché il tampone rapido non è affidabile al 100%, la certezza di precisione della diagnosi varia dal 70 al 90 per cento a seconda della qualità del test. Quello che ci stanno chiedendo quindi, è di rischiare di trasformare i nostri studi in potenziali focolai per fare un tampone che non è neanche appropriato per la funzione che gli vorrebbero assegnare».
Bastava poco (le scelte che si potevano fare)
Si sarebbe potuto agire diversamente e meglio? Lasciamo rispondere Luzzi, il medico sulla terra: «Beh, mi pare evidente: avrebbero dovuto lasciare fin da subito a noi medici di medicina generale il compito di decidere a chi fare i tamponi, e quando dico subito parlo di marzo. Il dipartimento di prevenzione, invece di essere oberato con il commissionare i tamponi, avrebbe invece potuto e dovuto tracciare i contatti delle persone risultate positive. Diagnosi e tracciamento, funzioni fondamentali che sono saltate. Si potevano fare assunzioni e mettere in piedi un call center regionale: per avvertire al telefono le persone che hanno avuto un contatto con un positivo e invitarle a fare il tampone non occorre essere laureati in medicina! Aggiungo anche che si poteva tranquillamente salvare la didattica in presenza, bastava utilizzare nelle scuole, lì sì, i tamponi antigenici rapidi per monitorare le classi senza chiudere nulla. Ma niente di tutto questo è stato fatto. E si sono prodotti i danni che abbiamo sotto gli occhi, oltre a trattare noi medici di medicina generale come professionisti di serie B. Ripeto: noi abbiamo in anticipo di un mese lo scenario che i vertici riceveranno sotto forma di dati. Era da agosto-settembre che si cominciavano a registrare sempre più casi sospetti, ma noi non potevamo decidere a chi fare i tamponi in autonomia, ci si costringeva a stare ore al telefono per segnalare i casi. E per di più ci hanno continuato a condannare a passare troppa parte del nostro tempo a scrivere e consegnare ricette. Si poteva fare molto meglio, si potevano probabilmente salvare persone. E, come ho cercato di dirti e dire a molti altri durante questi mesi, bastava poco».